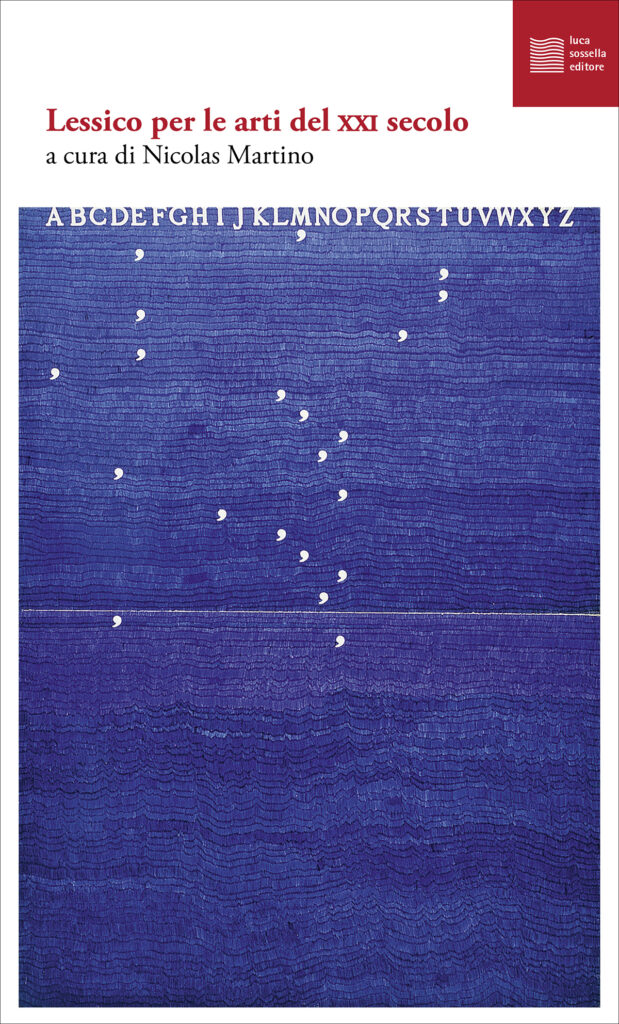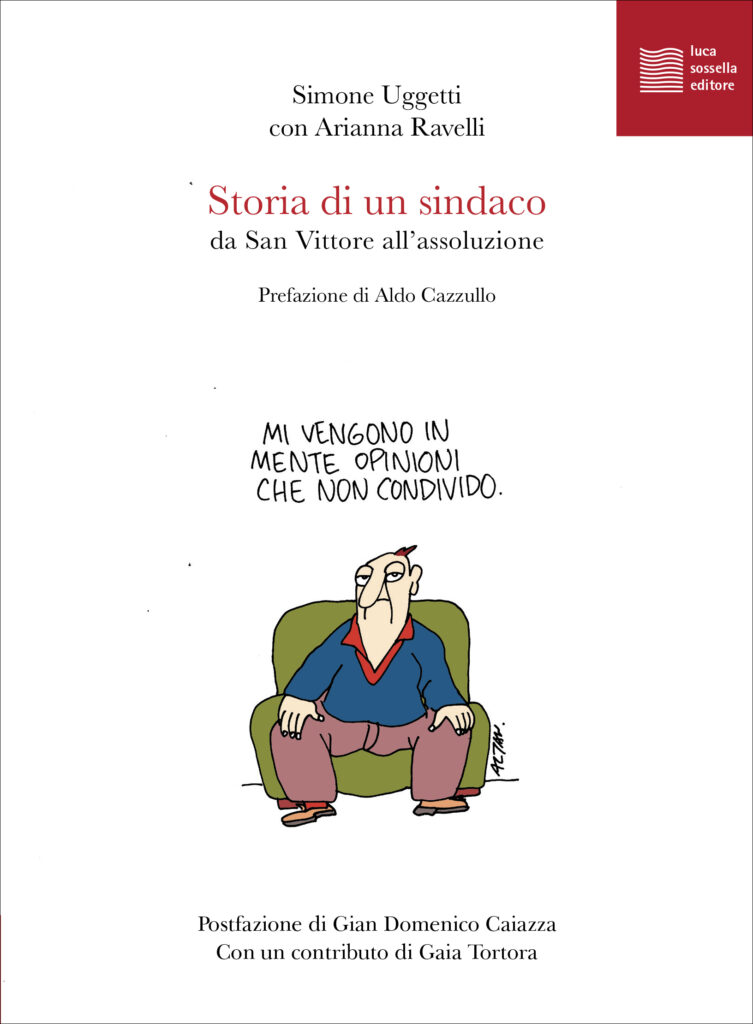Una prospettiva critica sui teatri documentari
Forse non siamo pronti per il teatro documentario, è troppo forte il contraccolpo che genera nelle nostre consuetudini di visione e percezione. Quello documentario è un teatro diffuso in ambito europeo anche nelle grandi sale, mentre in Italia siamo più abituati a spettacoli che orchestrano registicamente e scenicamente racconti di finzione. Quando è documentario, il teatro usa il reale come fonte e come lingua in tutte le sue manifestazioni: nel processo di ricerca, che avviene all’esterno e non solo nella sala prove; nelle vicende raccontate, tipicamente prossime all’attualità o provenienti dalle biografie di chi è in scena; grazie alle presenza di attori e attrici spesso non professionisti. Ma attenzione: questo “usare il reale” non significa fare a meno della finzione e qui probabilmente la nostra percezione difetta, drogata da sovrastimolazioni rappresentative. Per misurare il livello di credibilità eravamo abituati a usare un parametro di mimesi dicendo “sembra un film” (tenendo ferma la distinzione fra finzione e “originale”), mentre ora le immagini delle intelligenze artificiali imitano “solo” la finzione, dunque una realtà iper-trasformata, ritmata e suddivisa in frames. Ma cosa accade quando di fronte a noi ri-vediamo pezzi che ci riportano al punto di partenza, a quella realtà che sembra scomparsa dal nostro percepire? Ci sembra una domanda da porsi subito, è qui infatti che il teatro documentario s’incunea.
Facendo un passo non eccessivamente specialistico, diremmo che il teatro documentario sgretola quote di “rappresentazione”, recuperando stati di presenza che tendono alla “presentazione” senza mai risolversi in essa. È forse la forma artistica che scrive «il più vicino possibile alla realtà» come sostengono Erica Magris e Beatrice Picon-Vallin, un approssimarsi da intendersi come invito a una corrispondenza fra realtà e finzione, come due amiche d’infanzia che si mandano delle lettere. Per questo non possiamo dimenticare quanto il teatro documentario sia tangente alle ricerche sulla “presenza” tipiche della performance e della danza contemporanea, quanto conosca bene anche le tecniche di immedesimazione e rappresentazione del lavoro autoriale di attori e attrici, si serva dell’invenzione scenica registica e a tutti questi elementi aggiunga anche la narrazione spesso autobiografica.
La componente documentaria del teatro sta dunque in quel lavorio che trasforma le persone e le loro storie in “racconti”, di fatto “scrivendo la realtà” attraverso il montaggio drammaturgico, la messa in forma quasi coreografica di corpi e gesti, l’intervento sull’ambiente scenico con luci e musiche, e così via. Di fronte a noi ci sono pezzi di realtà che in prima istanza appaiono “non trasformati” ma, a ben vedere, le stesse presenze che calpestano le assi del palco occupano l’intercapedine fra la finzione del personaggio e la quotidianità della persona. C’è dunque uno sprone a “reimparare a percepire”, a guardare fra le righe, perché una storia esiste se si decide di tramutarla in racconto.
Come accade nel cinema del reale, anche il teatro documentario integra nell’esito finale la narrazione del processo, proiettando la sua portata oltre le singole repliche. Mentre stiamo scrivendo A Place of Safety. Viaggio nel Mediterraneo centrale è in scena a Roma al Teatro Vascello e due attori del cast, Miguel Duarte e Flavio Catalano, sono assenti dalla scena perché imbarcati sulla Global Sumud Flotilla, iniziativa umanitaria per rompere l’assedio e il massacro a Gaza. Al loro posto sono stati ingaggiati alcuni attori professionisti ai quali è stato chiesto di leggere le battute degli assenti. Uno spettacolo, dunque, così vicino al reale da poter mutare sensibilmente di replica in replica.
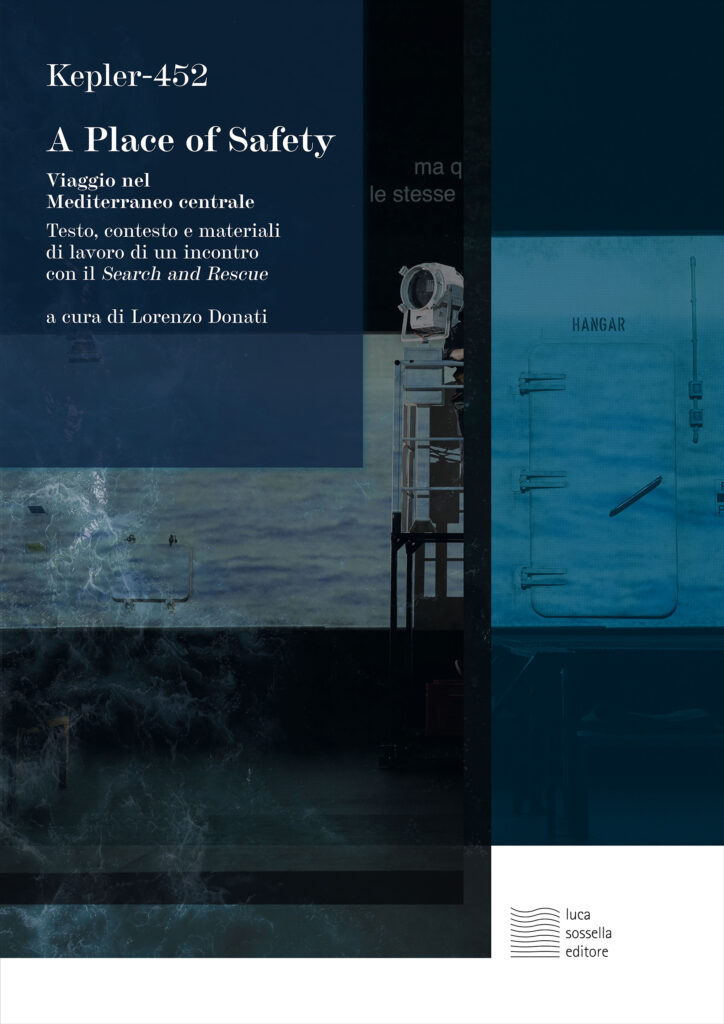
Anche il presente volume ambisce a porsi come itinerario di scoperte e approfondimenti attorno al corpo vivo dell’opera. Nella prima parte, si trovano alcune coordinate per orientarsi nella vicenda della Search and Rescue (ricerca e soccorso) a cui si aggiunge un profilo biografico di Kepler-452. Si tenta in seguito di dare rilevanza al processo attraverso le interviste ai due fondatori della compagnia, alle attrici e agli attori e con gli scritti di alcuni collaboratori alla creazione: la coreografa e attrice Marta Ciappina, il delegato sindacale, operaio e autore Dario Salvetti, il ricercatore Giovanni Zanotti. La terza sezione amplia il ragionamento in una dimensione europea, convocando due fra i massimi esperti di teatro documentario: Erica Magris (Università Paris 8) colloca il lavoro di Kepler-452 in un orizzonte di risonanze poetiche e stilistiche, portando i nostri spunti introduttivi in una dimensione compiutamente storica; infine Olivier Neveux, docente all’Università di Lyon, invita a pensare al teatro politicamente nel rapporto tra individuo e collettività, fra processi decoloniali e ansie del realismo.
Proseguiamo, dunque, seguendo la pista del racconto delle migrazioni a teatro.
[dalla prefazione al testo A Place of Safety. Viaggio nel Mediterraneo centrale, collana Linea in collaborazione con Emilia Romagna Teatro Fondazione]
Nota sul Search and Rescue e sul concetto di “porto sicuro”
Il termine Search and Rescue (SAR) indica le operazioni di ricerca e salvataggio di persone in pericolo in mare, una pratica regolata da convenzioni internazionali e oggi al centro di accesi dibattiti. Il concetto di “porto sicuro”, a sua volta, definisce il luogo in cui terminano le operazioni di soccorso e in cui la vita dei naufraghi non è più minacciata.
Supponiamo di essere nati in un paese al di fuori della cosiddetta area Schengen, confini europei entro i quali, dal 1985 in avanti, è iniziato un processo per l’abbattimento delle frontiere interne. Supponiamo, per un nostro desiderio di cambio vita, di volere raggiungere l’Europa. Per arrivarci anche per pochi giorni serve un visto, mentre per risiedervi stabilmente un permesso di soggiorno. Se fossimo nati in aree ricche del pianeta, e se ci si può permettere un viaggio di andata e ritorno, il visto è più o meno garantito. I problemi cominciano se il nostro paese di provenienza è afflitto da guerre, dittature o regimi che limitano le libertà personali: gli uffici di ambasciate e consolati che concedono i visti non ci permetterebbero di viaggiare. A pensarci sembra strano, ma a tantissime persone viene proibito di uscire dai confini dei propri stati, a meno di presentare cospicue garanzie economiche e lavorative. Ci sono alcune eccezioni: i ricongiungimenti famigliari (se si ha parenti già stabilmente regolarizzati in Europa) e, in Italia, i cosiddetti “decreti flussi”, che dovrebbero permettere di ottenere permessi di soggiorno di lavoro, ma il cui iter risulta molto farraginoso sia per i lavoratori che per i datori di lavoro. Per tutti gli altri casi non resta che la clandestinità integrale (arrivando illegalmente) o quella parziale, restando dopo la scadenza dei visti turistici (ammesso di averlo ottenuto), sperando di trovare lavoro in seguito o di regolarizzarsi attraverso le sanatorie.
Va detto che tra 2000 e 2010 solo il 9% dei flussi migratori fra le ex-colonie e l’Europa è avvenuto tramite viaggi nel Mediterraneo. Tutta la restante parte è stata originata da visti turistici ottenuti e usati per restare, da ricongiungimenti famigliari o dall’ottenimento di asilo politico. La criminalizzazione dell’immigrazione, in Italia, si è dunque orientata esclusivamente sul Mediterraneo nonostante il 90% delle persone in transito non provenga dal confine marittimo.
Supponiamo dunque di far parte di quel 9% di persone che è deciso a raggiungere l’Europa via mare. Ci è stato negato un visto turistico, o non siamo nelle condizioni di chiederlo perché non abbiamo ingenti coperture economiche. Ci mettiamo in viaggio pagando dei passaggi salatissimi ai trafficanti delle coste, che spesso ci lasceranno in balìa delle onde su imbarcazioni di fortuna. Se dovessimo trovarci in difficoltà, questo è lo scenario che ci si presenta. Fino all’inizio degli anni Dieci in Italia la Marina Militare e la Guardia Costiera conducevano operazioni di pattugliamento e salvataggio, con il preciso obiettivo di salvare vite umane (es. l’operazione Mare Nostrum, del 2013). In questo quadro si è sviluppata l’azione di Search and Rescue (SAR) svolta da diverse Organizzazioni Non Governative internazionali, organizzazioni che inizialmente cooperavano con le autorità locali per un comune obiettivo. Nel tempo, il ritirarsi delle autorità nazionali ha lasciato il campo alle ONG: secondo l’European Union Agency for Fundamental Rights le ONG avevano effettuato circa il 40% dei soccorsi nella prima metà del 2018. Da metà degli anni Dieci si è aggiunta una campagna di criminalizzazione sul triplice piano politico, mediatico e giudiziario cui è corrisposta un’effettiva smobilitazione: diversi processi sono stati intentati verso ONG accusate di favorire l’immigrazione clandestina, in un diabolico ribaltamento di prospettiva (si accusa chi si preoccupa di salvare vite, mentre gli stati Europei stanno a guardare) e con l’utilizzo del paradigma d’indagine mafioso che è arrivato, in alcuni casi, a ricorrere persino all’associazione a delinquere contro chi salva vite in mare; intanto in Italia i ministri di Centrodestra hanno completato quanto era stato iniziato prima dai ministri di Centrosinistra, perché fra chiudere i porti di Salvini e stringere accordi per i respingimenti di Minniti la differenza è poca. Nel Mediterraneo centrale gli stati hanno dunque deciso di impiegare sempre meno risorse, spostandole sulla difesa dei confini: in questo consiste l’Agenzia europea Frontex, mentre l’Italia ha stretto accordi con la Libia fornendo risorse, armi e mezzi di trasporto marittimo con il preciso scopo di respingere le imbarcazioni, spesso aprendo il fuoco e detenendo le persone in condizioni disumane. Un accordo simile è stato stretto con la Tunisia nel luglio 2023. Dal primo Memorandum Italia-Libia del 2017 (rinnovato tacitamente il 2 novembre 2025), il nostro Paese è di fatto complice di uno Stato che diverse organizzazioni internazionali tra cui l’ONU, Amnesty International, Medici Senza Frontiere e Save the Children hanno denunciato per torture, detenzioni arbitrarie, violenze sessuali e trattamenti disumani.
Quello che invece fanno le ONG, in tale clima di criminalizzazione, è salvare vite attenendosi all’allegato alla convenzione SAR del 1979, paragrafo 1.3.2. In questo testo si definisce “porto sicuro” un luogo in cui le operazioni di salvataggio sono terminate e dove la sicurezza della vita dei sopravvissuti non è più minacciata, dal momento che i bisogni umani fondamentali (come cibo, riparo e cure mediche) possono essere soddisfatti. “A Place of Safety” è un luogo da cui si possono prendere accordi per il trasporto dei sopravvissuti verso la loro destinazione successiva. Nonostante non vi sia una definizione univoca, le convenzioni e alcuni strumenti di “soft law” (come le linee guida della IMO – Organizzazione Marittima Internazionale e le ExCom decisions dell’UNHCR, Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati) forniscono elementi utili per stabilire che la nave che ha effettuato il soccorso può essere solo temporaneamente un Place of Safety. I governi dovrebbero cooperare tra di loro per fornire un porto sicuro adeguato ai sopravvissuti dopo aver considerato rischi pertinenti. Va chiarito che, nel caso di richiedenti asilo e dei rifugiati recuperati in mare, è da evitare lo sbarco in territori dove le vite e le libertà sarebbero minacciate da fondati timori di persecuzione.